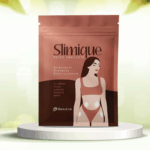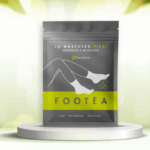Se sei tra coloro che consumano caffè ogni giorno, forse ti sei chiesto se questa abitudine possa avere effetti negativi sulla salute e, in particolare, se esista davvero una sostanza potenzialmente cancerogena all’interno della celebre bevanda nera. Il caffè è da sempre uno degli argomenti più discussi nei dibattiti tra nutrizionisti, ricercatori e appassionati del benessere, anche a causa del suo contenuto di composti bioattivi, tra cui si annovera non solo la caffeina, ma anche alcune sostanze che si formano durante la torrefazione dei chicchi.
La sostanza sotto accusa: acrilammide
Il sospetto che il caffè possa contenere componenti cancerogeni nasce soprattutto dalla presenza dell’acrilammide, una molecola che si forma nei cibi ad alto contenuto di amido sottoposti a cotture ad alta temperatura, come il pane e le patatine, nonché durante la torrefazione del caffè. Studi condotti su animali hanno dimostrato che l’assunzione di elevate quantità di acrilammide può aumentare il rischio di sviluppare alcune forme di tumori, portando l’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) a classificare la sostanza come “probabile cancerogeno” per l’uomo.
Tuttavia, è importante sottolineare che le dosi di acrilammide assunte attraverso il caffè sono nettamente inferiori rispetto a quelle usate negli esperimenti sugli animali. Numerosi organismi regolatori, tra cui l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), hanno più volte confermato che il normale consumo di caffè non espone a livelli di acrilammide tali da giustificare un aumento significativo del rischio tumorale.
Il verdetto della comunità scientifica
Per diverso tempo il caffè è stato osservato con diffidenza, anche a seguito di ricerche condotte nei decenni passati che lo avevano inserito tra le sostanze potenzialmente rischiose per la salute umana. Nel 1991, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva collocato il caffè tra i possibili cancerogeni a causa di dubbi emersi da alcuni studi epidemiologici, in particolare per un sospetto collegamento con il tumore alla vescica. Tuttavia, la revisione di questi dati ha fatto emergere un punto fondamentale: molti dei forti consumatori di caffè erano anche grandi fumatori, e il consumo di tabacco rappresenta uno dei principali fattori di rischio per numerosi tipi di cancro, generando un fattore confondente nei risultati di queste ricerche.
Quando la scienza ha iniziato a correggere questi errori metodologici, separando l’impatto del fumo da quello del caffè stesso, gli studi più recenti hanno smontato il sospetto di una responsabilità diretta del caffè nello sviluppo del cancro. Anzi, le indagini più aggiornate riportano un possibile effetto protettivo contro alcune neoplasie, in particolare per il tumore del fegato e dell’endometrio. Il caffè contiene infatti composti quali caffeina, acido clorogenico e catechine che, secondo alcune evidenze, potrebbero favorire i meccanismi di detossificazione dell’organismo e di riparazione del DNA.
Il caso della caffeina e le evidenze sui rischi
Un interrogativo legato al consumo quotidiano di caffè riguarda la presenza di caffeina, l’alcaloide responsabile dell’effetto stimolante tanto apprezzato dagli amanti dell’espresso. Pur essendo una sostanza considerata sicura alle dosi normalmente consumate, la caffeina è dotata di una tossicità intrinseca se assunta in quantità eccessive, e potrebbe portare a sintomi come agitazione, ansia e aritmie cardiache se si superano i 400 mg al giorno, ovvero l’equivalente di circa 5 tazzine di caffè per un adulto di corporatura media.
Caffeina e rischio cancerogeno
Quanto alla potenzialità cancerogena, la caffeina non rientra tra le sostanze classificate come tali sulla base delle conoscenze attuali. Il caffè, come bevanda, è stato oggetto di ampia revisione da parte della stessa IARC che nel 2016 ha definitivamente stabilito che non esistono prove scientifiche sufficienti per affermare che il caffè sia responsabile di un incremento nel rischio di cancro, neppure considerando la caffeina in esso contenuta.
Va però ricordato che l’effetto del caffè sull’organismo può variare notevolmente tra individuo e individuo, a seconda della genetica, delle abitudini di vita (incluso il fumo), dell’età e dello stato di salute generale.
Caffè, tumori e le ricerche più recenti
Le più accurate e autorevoli meta-analisi degli ultimi anni, compresi i rapporti del World Cancer Research Fund e dell’IARC, riconoscono che il caffè non è una sostanza cancerogena nella dieta umana quotidiana. Alcuni studi suggeriscono persino una certa azione protettiva nei confronti di alcune forme tumorali, come il tumore del fegato, dell’endometrio e, forse, il melanoma, grazie all’interazione con meccanismi molecolari che favoriscono la risposta antiossidante e la riparazione del danno cellulare.
Risultati più contrastanti riguardano i possibili effetti antinfiammatori del caffè sul microbiota intestinale, e l’impatto sulla progressione dei tumori in pazienti già malati. La variabilità dei risultati, però, dipende spesso dalle differenze metodologiche tra i vari studi e dalla complessità dell’interazione tra caffè e organismo.
- L’acrilammide presente nel caffè è classificata come probabile cancerogeno se assunta in dosi elevate, ma il suo contenuto nella dieta quotidiana è molto basso.
- La caffeina ha un profilo di sicurezza elevato se consumata entro le dosi raccomandate, ma un abuso può causare effetti tossici senza però incrementare il rischio di tumore.
- Le ricerche scientifiche più attuali escludono il caffè dalla lista delle sostanze cancerogene alimentari, riconoscendo invece alcuni possibili benefici per la salute.
- Il rischio cancerogeno attribuito al caffè in passato era confuso dall’associazione con il fumo, che rappresenta di gran lunga un fattore di rischio superiore per il cancro.
Il vero consiglio, oggi, è quello di fare riferimento alle linee guida ufficiali sulla sicurezza alimentare: moderazione e uno stile di vita globale orientato al benessere rimangono i migliori alleati della salute. Il caffè, se inserito in una dieta equilibrata e uno stile di vita sano, non costituisce un rischio degno di preoccupazione per la salute oncologica, e il suo contributo come fonte di composti bioattivi resta un interessante campo di ricerca per futuri approfondimenti nutrizionali.